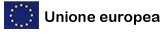Il bullismo e il cyberbullismo sono caratterizzati da manifestazioni violente e intenzionali, di tipo verbale, fisico, sociale, ripetute nel tempo da parte di un singolo o da più persone, anche online (cyberbullismo).
Esiste uno squilibrio di potere tra chi aggredisce, per ferire e umiliare, e chi subisce e non riesce a difendersi.
Si tratta di fenomeni che esprimono scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è ritenuto diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.
Il bullismo non riguarda principalmente i ragazzi/ragazze delle scuole superiori
Secondo i dati della Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022, gli atti di bullismo subìti a scuola sono più frequenti nei più piccoli (11 – 13 anni) e nelle ragazze; per il bullismo le proporzioni sono simili a quelle del 2017/18. Il fenomeno del cyberbullismo è in crescita nelle ragazze e nei ragazzi di 11 e 13 anni. I due fenomeni decrescono al crescere dell’età.
Gli 11enni vittime di bullismo sono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze; nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine; gli adolescenti (15 anni) sono il 9,9% dei ragazzi e il 9,2% delle ragazze.
Strettamente correlato al bullismo è il fenomeno della violenza domestica. I minori esposti a episodi di violenza familiare sono più propensi a esercitare forme attive di bullismo nei confronti dei compagni o a essere vittime di bullismo.
Il cyberbullismo
Il cyberbullismo è un fenomeno che si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di preadolescenti e adolescenti. La facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente al cyberbullo di commettere atti di violenza fisica e/o psicologica, anche in anonimato, mediante i social network, e di offendere la vittima mediante la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la creazione di gruppi contro. Si tratta di un uso inappropriato della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati diversi per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perché stranieri.
Nella fascia di età 11 anni risultano vittime di cyberbullismo il 17.2% dei maschi e il 21,1% delle femmine; i 13enni coinvolti sono il 12,9% dei ragazzi e il 18,4% delle ragazze; gli adolescenti di 15 anni sono il 9,2% dei maschi e l’11,4% delle femmine.
La sorveglianza Health Behaviour in School - aged Children - HBSC Italia 2022
Per comprendere appieno la dimensione e la diffusione di alcuni comportamenti a rischio che si instaurano spesso in età pre-adolescenziale e adolescenziale è attivo dal 1983 lo studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), cui l’Italia partecipa dal 2001. Tale studio è promosso dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e coinvolge ogni 4 anni, nei 44 paesi aderenti, un campione di studenti di 11, 13, 15 e 17 anni.
L’indagine rappresenta lo strumento nazionale per il monitoraggio dei fattori e dei processi che possono determinare effetti sulla salute degli adolescenti, attraverso la raccolta di dati sulla salute, sui comportamenti a essa correlati e sui loro determinanti.
La fotografia dei comportamenti degli adolescenti è stata scattata dalla rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, promosso dal Ministero della Salute e dal CCM - Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie del Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali.
Nella rilevazione 2022, i ragazzi di 11, 13, 15 e 17 anni che hanno risposto al questionario sono stati 94.178 distribuiti in tutte le Regioni italiane (con un tasso di rispondenza complessivo pari al 97%); le classi campionate sono state 6.388, distribuite anch’esse in tutte le Regioni d’Italia (con un’adesione pari all’88,8%). L’elevata partecipazione, sia dei ragazzi che delle classi, è indicativa di un buon livello di sinergia tra il settore scolastico e il settore sanitario, nonché di una sensibilità particolare delle famiglie dei ragazzi verso i temi affrontati.
Scuola, rapporto tra pari, bullismo e cyberbullismo
L’HBSC indaga anche alcuni aspetti del contesto di vita familiare e scolastico, come ad esempio il rapporto con i genitori, con i compagni di classe, gli insegnanti, i pari, il bullismo e il cyberbullismo. La rilevazione riferisce che all’interno delle famiglie, al crescere dell’età diminuisce la facilità con cui i ragazzi si aprono ad entrambi i genitori; le ragazze di 13 e 15 anni, rispetto ai ragazzi coetanei, hanno una maggiore difficoltà a parlare con la figura paterna. In generale, il 68% dei ragazzi e il 60% delle ragazze dichiara livelli elevati di sostegno familiare; nei 15enni questa % si abbassa fino al 52% nelle ragazze e al 61% nei ragazzi e si nota un trend negativo rispetto alla rilevazione del 2017/18.
Dichiara di avere amici con cui condividere gioie e dispiaceri l'87% dei ragazzi di 11 anni, il 79% dei ragazzi di 13 anni e l’80% dei ragazzi di 15 anni; dichiara di poter parlare dei propri problemi con gli amici il 76% dei ragazzi di 11 anni, il 69% dei ragazzi di 13 anni e il 70% dei ragazzi di 15 anni.
Infine, in merito al rapporto positivo con i compagni, il 76,5% dei ragazzi di 11 anni, il 63,1% dei ragazzi di 13 anni, e il 66,6% dei ragazzi di 15 anni si sente accettato dai propri compagni.
Dichiara di avere un rapporto positivo e di fiducia con gli insegnanti l’85,7 % dei ragazzi di 11 anni, il 75% dei ragazzi di 13 anni e il 61,8% dei ragazzi di 15 anni.
La rilevazione pone attenzione anche alla sensazione di stress per la scuola, che risulta essere più ampia tra le ragazze, in aumento con l’aumentare dell’età e con un trend in peggioramento rispetto alla rilevazione 2017/18.
Il bullismo continua a vedere l’Italia tra i paesi meno interessati dal fenomeno rispetto al complesso di quelli coinvolti nella rilevazione.
Bullismo e cyberbullismo: un serio problema di salute pubblica
Le evidenze disponibili sugli effetti negativi sulla salute, intesa nel senso più ampio del termine, dimostrano quanto il fenomeno sia da considerare un serio problema di salute pubblica.
Il fenomeno ha origine prevalentemente in ambito scolastico e rappresenta una fonte non trascurabile di costi per il sistema economico, sociale, educativo, e giudiziario. Diversi studi indicano anche un’associazione fra essere stato vittima di atti di “bullismo” e abbandono scolastico.
Il bullismo è associato a problemi di salute nel periodo adolescenziale che includono disturbi d’ansia e dell’umore, ideazione suicidaria, autolesionismo e disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente (disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio), ma è anche associato a un maggior rischio di soffrire di disturbi correlati ad abuso e dipendenza da alcol e/o sostanze psicoattive.
La valutazione degli esiti di chi nel corso dell’adolescenza è stato vittima di bullismo nella scuola elementare ha mostrato un aumento del rischio di insorgenza di disturbi somatici, della personalità, psicotici e di tabagismo. In adulti vittime di bullismo in età infantile o adolescenziale sono stati osservati rischi aumentati di avere problemi di salute fisica e nell’ambito delle relazioni sociali e dell’inserimento lavorativo.
Cosa fare
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, per la complessità che lo caratterizza e per la delicatezza dell’ambito di interesse, relativo alla crescita, alla vita quotidiana dei ragazzi e quindi alla loro salute, impone che grande attenzione sia posta alle persone coinvolte che, solo apparentemente, sono la vittima e l’autore del gesto. Testimoni, genitori, insegnanti, amici, pediatri, sono tutte figure con un ruolo potenzialmente decisivo per intercettare, sostenere e interrompere una azione fisicamente e psicologicamente dolorosa. Per tale ragione è necessario realizzare azioni sinergiche di prevenzione e di intervento precoce, utilizzando la scuola come contenitore privilegiato di tali azioni. Evidenze consolidate dimostrano che i trattamenti più efficaci per le condotte antisociali riguardano lo sviluppo di competenze emotive e relazionali attraverso attività scolastiche che iniziano precocemente, ovvero in età infantile e pre-adolescenziale, e promuovono la cosiddetta “salute mentale positiva” degli studenti (controllo dell’aggressività, resilienza, autostima, autoefficacia), mediante il potenziamento di abilità come la capacità di autoregolazione delle emozioni, di definizione di obiettivi personali, di problem solving e di abilità relazionali. Ciò consente di prevenire fenomeni di discriminazione, marginalità sociale e persecuzione in ambito scolastico che possono dar luogo a forme di aggressività e incidere irrimediabilmente sulla personalità e sulla salute mentale delle vittime. Gli interventi più efficaci per la prevenzione e la cura del bullismo sono sostanzialmente gli stessi che per gli altri tipi di disagio giovanile.
Un importante traguardo raggiunto è rappresentato dalle nuove disposizioni normative contro il fenomeno del cyberbullismo. Con la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, sono stati definiti il fenomeno, gli obiettivi della legge, caratterizzati da azioni a carattere preventivo e da una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
Per approfondire consulta:
-
Epicentro - sito tematico Health behaviour in school-aged children
-
Comitato paritetico per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione
-
News Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo - 2024













 Giornata nazionale della salute della donna
Giornata nazionale della salute della donna